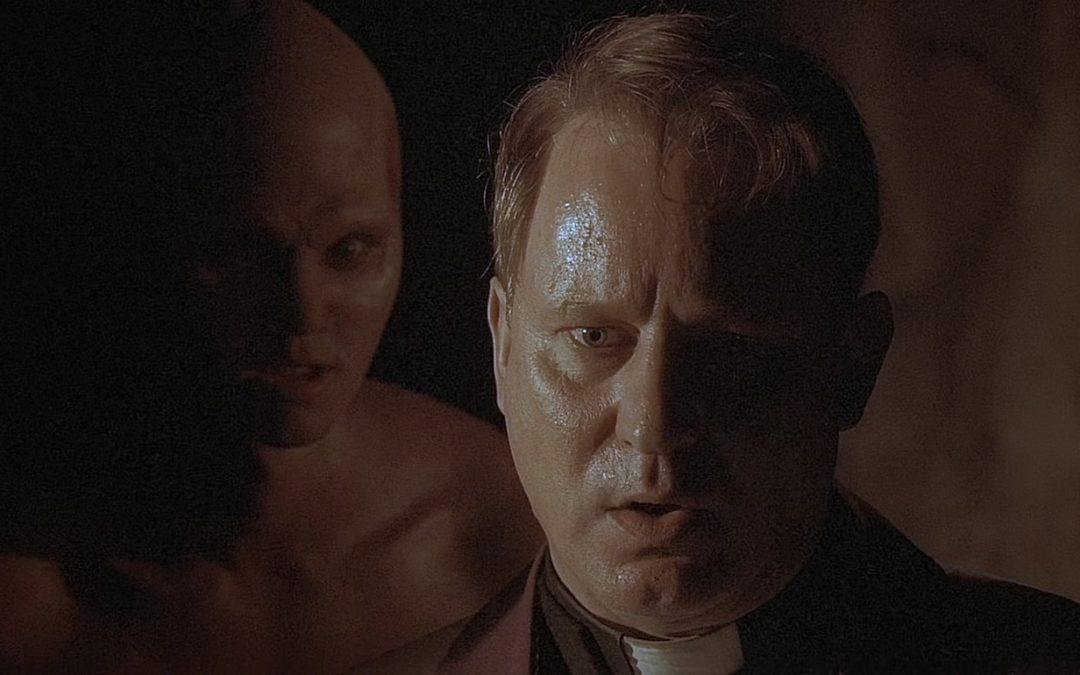Non di rado attori e attrici passano dall'altro lato della cinepresa, talvolta con risultati discreti ma dimenticabili, specialmente quando dirigono se stessi, in altri casi però riescono a dimostrare una visione tanto personale da fare invidia a numerosi registi con anni di esperienza alle spalle. Di questa categoria fa senza dubbio parte Charlotte Le Bon, che dopo aver recitato in notevoli produzioni internazionali debutta alla regia di un lungometraggio con Falcon Lake. Presentato all'edizione 2022 del Festival di Cannes, il film ottiene il plauso unanime della critica, compresa quella italiana, mentre il pubblico nostrano può recuperarlo da qualche mese in streaming tramite Rai Play.
Protagonista della pellicola è Bastien (Joseph Engel), tredicenne francese in vacanza in Canada con la famiglia, grazie alla quale conosce Chloé (Sara Montpetit), più grande di tre anni ma con cui instaura in breve tempo un rapporto molto speciale dopo aver parlato del presunto fantasma che aleggia sul lago intorno al quale trascorrono le vacanze estive.
Dall'ormai lontano XVIII secolo, grazie al più noto romanzo scritto da Goethe, la narrativa ha iniziato a interessarsi sempre di più al processo di maturazione degli adolescenti, dando vita a quel genere denominato romanzo di formazione o Bildungsroman. Falcon Lake rientra appieno in questo tipo di racconto, in special misura per quanto concerne la scoperta dell'amore. Materiale dunque tutt'altro che nuovo ma che, come ci insegnano i maestri dell'arte di raccontare, può sempre colpire il pubblico per il modo in cui queste esperienze così vicine a tutti noi vengono messe in scena. Le Bon, nonostante sia alla sua prima prova registica, dipinge, quasi letteralmente, un'opera di raro lirismo, chiaramente figlia di precedenti cantori dell'adolescenza come Rohmer o Truffaut ma in grado di divincolarsi dal semplice manierismo tramite un'interessante commistione con atmosfere e persino elementi narrativi tipici del gotico anglosassone. La plumbea luce che emana l'ambiente del lago, così caro anche ad autori ottocenteschi quali Coleridge e Mary Shelley, così come i costanti riferimenti a presunte presenze fantasmatiche, donano al lento e inesorabile sviluppo di un sentimento in grado di legare fortemente Bastien e Chloé, al netto delle tante differenza caratteriali e di modi di vivere, un retrogusto tetro. La morte sembra aleggiare sempre dietro l'angolo, aumentando anche il senso di urgenza e precarietà tipico del primo amore, che per quanto potente e sconvolgente possa essere vive sempre su un sottilissimo filo, finendo quasi sempre per esaurirsi in un tempo tanto breve quanto impossibile da dimenticare.
Per esprimere al meglio questo singolare coming of age gotico la cineasta franco-canadese opta per un approccio totalmente distante dalla visione hollywoodiana del filone, privilegiando i silenzi allo sproloquio, la luce naturale, persino nelle sequenze notturne, all'illuminazione posticcia di tanti teen movie e una coppia di attori protagonisti estremamente credibili, sia per età che per la capacità di rendere palpabile tutta la frenesia erotica della scoperta di sé. Il climax con cui i due si avvicinano sempre di più viene scandito anche da un crescendo dal punto di vista fisico, proprio a sottolineare quanto sensoriale, tattile e misterioso sia l'innamoramento tra ragazzi, come evidenziato dall'insistenza sui morsi alle mani o dai tanti contatti fisici precedenti alla vera e propria esperienza sessuale tra Bastien e Chloé.
Se il buongiorno si vede dal mattino Falcon Lake rappresenta il migliore degli auspici possibili per la carriera da cineasta di Le Bon, avendo diretto uno dei migliori racconti di formazione girati da anni e un'opera prima da ricordare a lungo.