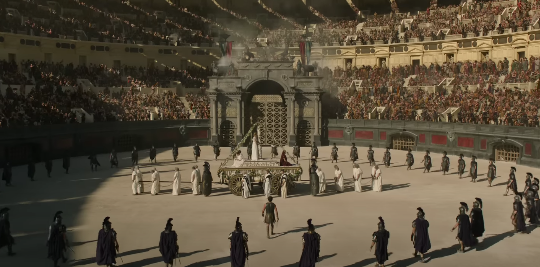Nonostante una pletore di titoli divenuti iconici nel corso dei decenni, a cominciare da uno dei primi esempi quale Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 1955), i teen movie sono sempre visti con un certo sospetto, quasi come se vi fosse qualcosa di intrinsecamente sciocco o banale nelle storie aventi come protagonisti gli adolescenti. Discorso che peraltro si riverbera in qualunque medium e non solo nel cinema, dai romanzi passando per la musica. Ciononostante molti autori riconosciuti o giovani promesse si sono cimentate con questa tipologia di racconto. Tra di essi figura anche Gia Coppola, nipote del leggendario autore di Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979) tra gli altri, impegnata quest'anno con The Last Showgirl (2024) ma che esordisce al lungometraggio nel 2013 con Palo Alto, tratto dall'omonima raccolta di racconti brevi a opera di James Franco, qui presente nelle vesti a lui più congeniali di attore. Prodotto con un budget piuttosto basso per gli standard statunitensi, il film viene presentato al Festival di Venezia, dove riceve recensioni perlopiù positive e, successivamente, buoni riscontri anche al box office, aprendo alla nipote d'arte la possibilità di una intrigante carriera nel cinema di fiction.
Ambientata nell'omonima città californiana, la pellicola segue la vita di tutti i giorni di un gruppo di ragazzi, alle prese con scuola, sport, feste a base di alcol e canne, esperienze sessuali spesso occasionali e i primi scontri con l'imminente età adulta. Tra di essi vengono seguiti con particolare attenzione April (Emma Roberts), talento della squadra liceale di calcio che inizia una relazione con il proprio allenatore (James Franco), e Teddy (Jack Kilmer), la cui vocazione artistica viene messa in secondo piano dalle bravate che combina insieme al migliore amico Fred (Nat Wolff).
Uno dei numerosi motivi pregiudizi verso il teen movie a cui accennavo precedentemente è quello di spettacolarizzare la vita dei ragazzi, in un tripudio di glamour e cliché narrativi in cui la caratterizzazione degli stessi finisce per essere estremamente bidimensionale e prevedibile. Palo Alto segue una direzione completamente opposta, non perché si discosti dai tipici problemi e temi legati a quella particolare età, bensì perché porta lo spettatore all'interno della quotidianità di adolescenti qualunque, come lo siamo stati tutti noi. La macchina da presa di Coppola, che dimostra anche un notevole gusto per la composizione delle inquadrature, segue i personaggi con la rara sensibilità di chi vuole conoscere qualcuno senza però finire per giudicarlo, dando vita a una sorta di via di mezzo tra il pedinamento quasi documentaristico di Elephant (Gus Van Sant, 2003) e l'umanesimo ai limiti del realismo magico di Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999). Una scelta narrativa che potenzia notevolmente il coinvolgimento emotivo del fruitore, permettendogli di entrare in contatto con una realtà magari lontana nel tempo, sfidando la tentazione di analizzare a livello sociologico o etico quello che accade sullo schermo, atteggiamento tipicamente adulto e poco adolescenziale. Esemplare di questa volontà è il doppio dialogo che vede protagonisti prima Teddy e un'assistente sociale e successivamente April e il suo coach, nel quale entrambi i giovani esternano una mancanza di consapevolezza di ciò che anima alcune delle loro azioni, mentre la risposta dei più maturi interlocutori li rassicura sul fatto che sia una caratteristica essenziale della giovinezza, nonostante in realtà una motivazione forte sia presente eccome nel momento in cui agiscono.
E certamente tra questi motivi non può non esserci anche la difficoltà nel rapportarsi con gli adulti, che appaiono totalmente distaccati o assenti nei confronti della generazione che li succede, talvolta fisicamente ma spesso anche quando sono presenti almeno da quel punto di vista. Il personaggio di James Franco, ad esempio, che anagraficamente sarebbe il più vicino ai protagonisti, si dimostra tutt'altro che in grado di creare una relazione sana e reciproca con la giovane amante e le altre calciatrici, che tratta esclusivamente come oggetti sessuali e manipola emotivamente con atteggiamenti subdoli quali love bombing o evidenti ammiccamenti che però astutamente evita di trasformare in molestie palesi. La distanza abissale tra teenager e adulti viene evidenziata anche visivamente dall'autrice, attraverso un ampio ricorso da campi lunghi in cui i primi finiscono per essere quasi inghiottiti dalla fredda architettura in cui si muovono, a simboleggiare lo smarrimento quasi metafisico (si pensi ai dipinti di De Chirico) che provano aggirandosi in un mondo che ancora non conoscono abbastanza, senza alcuna guida che possa almeno aiutarli a conoscere meglio sé stessi. Una scelta estetica molto vicina al quasi coevo It Follows (David Robert Mitchell, 2014), che estremizza l'horror vacui della provincia americana in decadimento economico e sociale in un mostro mutaforma ma condivide il medesimo atteggiamento empatico verso i ragazzi della pellicola in analisi, così come anche una colonna musica ricca di suoni elettronici capace di enfatizzare il disorientamento dei personaggi.
Per comprendere la connessione quasi unica tra Palo Alto e l'età che tenta di descrivere basterebbe la scena finale, in cui i destini opposti di Teddy/April e Fred riescono a instillare nello spettatore quei due estremi emotivi che possono convivere solamente quando la vita adulta è un incomprensibile miraggio.